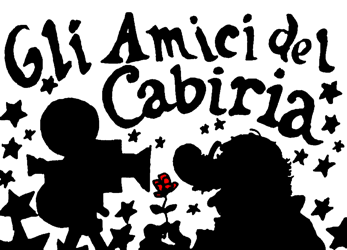Scheda
Regia: Diego Quemada-Diez
Paese: Messico
Anno: 2013
Durata: 102 min
Interpreti: Rodolfo Dominguez, Brandon López, Ramón Medína, Carlos Chajon, Karen Martínez
Trama
Il quindicenne Chauk è un indiano Tzetzal che vive nel sud del Messico, non parla spagnolo e non ha alcun documento. Il sedicenne Juan vive in Guatemala e non ha alcuna ragione per rimanere nella sua terra dopo l'omicidio di suo fratello, fugge così con Sara e Samuel. Chauk e i tre ragazzi si incontrano su un treno merci che attraversa il Messico per dirigersi a nord verso gli Stati Uniti in cerca di una vita migliore e, nonostante le loro differenze, scoprono il valore della fraternità, della solidarietà e della poesia.
Critica
Sorprendente opera prima sul tema dell'emigrazione in America Latina con uno stile che si fonda sulla realtà, pur non essendo un documentario né un film a tesi, anche se la posizione del regista è forte e chiara nella denuncia dello sfruttamento dei popoli “chiamati” negli Stati Uniti e poi lasciati senza documenti e quindi illegali «nella gabbia d’oro che non smette mai di essere una prigione». Queimada-Diez vanta una lunga esperienza come assistente al seguito di Oliver Stone, Alejandro Gonzalez Inàrritu e soprattutto Ken Loach, dal quale dice di aver preso molto: il metodo che ha seguito per girare è infatti più vicino al cinema documentario che a quello di finzione, vedi la scelta del Super 16, gli attori non professionisti, le riprese in sequenza, pochi movimenti di macchina e la scelta di luoghi reali. Ha impiegato dieci anni per raccogliere centinaia di interviste a immigrati di diversa età e provenienza che hanno attraversato la frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti (senza alcuna strumentazione che non fosse il taccuino e la penna, la videocamera sostiene sia un mezzo che altera la verità del racconto); queste han rappresentato la base per la scrittura di un film sì finzionale, ma completamente basato sul solco di storie vere.
Premi e Festival
“A Certain Talent Prize” e “Premio Gillo Pontecorvo” al Festival di Cannes, e Miglior Film al Giffoni Film Festival
Rubrica
«Le parole di un messicano di nome Juan Menéndez López, pronunciate pochi istanti prima che salisse a bordo di un treno merci in corsa insieme a sette suoi compagni, restano impresse nella mia mente: “si imparano molte cose lungo il cammino. Qui siamo tutti fratelli, abbiamo tutti le stesse esigenze. L'importante è che impariamo a condividere. Solo così potremo andare avanti, solo così potremo raggiungere la nostra destinazione, solo un popolo unito può sopravvivere. In quanto esseri umani, non siamo clandestini in nessun luogo del mondo”.» (Diego Quemada-Diez)
Dalla conferenza stampa col regista apparsa su www.sentieriselvaggi.it:
Quanto tempo ci è voluto a convincere i produttori a realizzare questo progetto?
Ho iniziato a cercare fondi per il film a Los Angeles, dove avevo girato un cortometraggio che era stato presentato al Sundance. Quando dicevo che volevo attori non professionisti i finanziatori insistevano affinché usassi almeno una voice over riconoscibile, proponendomi Salma Hayek, ma non era nei miei piani. Dopo sono andato in Messico, dove esistono ancora gli aiuti alla cultura, e ho cercato i produttori. Prima di trovare quelli giusti ne ho cambiati cinque, perché molti erano spaventati dalla situazione presente nel paese e anche la logistica era complessa con centoventi location. In realtà la cosa non era pericolosa come sembrava, sapevo a chi rivolgermi per avere i permessi. Ho parlato con i capi delle bande locali spiegando loro i motivi per cui volevo girare e mi hanno aperto le porte del quartiere.
Qual è stato il rapporto con la frontiera americana?
Il film mette in discussione il tema delle frontiere e delle bandiere – tutte costruzioni artificiali. Sono riuscito a ottenere dei visti per i ragazzi, anche se è stato difficile. Abbiamo poi parlato con la polizia di frontiera ma non ci ha aiutato e quindi abbiamo ricostruito questa zona nell’area messicana. Un ragazzo mi ha spiegato la sua conformazione: tunnel, muri, poi ancora tunnel e zone paludose, sembrava un campo di concentramento e da lì ho capito la politica fascista degli americani.
Come sono costruiti i personaggi?
Nei personaggi è presente una componente di finzione e una reale. Alcune cose potevano funzionare, altre no. Poi ho inserito dei riferimenti al film Shane (Il cavaliere della valle solitaria) e e a quelli di John Ford, come nella scena della gallina. Ho voluto costruire un poema epico dove si sentisse la forza del viaggio, del paesaggio e del treno. I ragazzi, però, non erano completamente in quel mondo. In più, molti elementi venivano da cose che ho visto: ad esempio ho incontrato una ragazza che aveva fatto lo stesso viaggio con la madre, e si era tagliata i capelli e aveva usato una fascia per il seno; un’altra donna mi ha raccontato che prima di partire aveva iniziato a prendere la pillola perché sapeva che sarebbe stata violentata. La costruzione dei personaggi viene quindi da più elementi, l’importante era che ognuno mettesse del suo per creare la realtà.
Com’è nata l’idea della neve?
Mi è venuta guardando Il settimo continente di Michael Haneke. È un’immagine che si ripete creando uno stato ipnotico. Mi chiedevo in che modo dare un tono poetico al film e alla fine ho scelto questa rima. Una volta poi un bambino mi ha detto che voleva andare negli Stati Uniti non per un futuro migliore ma per vedere la neve. Si tratta di un elemento che fa parte del processo di apprendimento del protagonista, che durante il viaggio perde l’innocenza e acquista qualcosa di diverso.
Qual è il suo rapporto con Ken Loach?
Ho fatto tre film insieme a lui, il primo è Terra e libertà. Mi ha colpito il suo metodo di girare in sequenza e anche il lavoro con gli attori che in questo modo capiscono cosa devono fare. Loach poi usa la macchina da presa a livello dello sguardo, senza fare ricorso a dolly o steadycam. Quello che apprezzo di meno è l’eccesso di sottolineatura politica. Per me è un elemento che deve essere meno marcato. Ad esempio nel film il conflitto tra l’indio e il protagonista emerge dal loro rapporto e non c’è stato bisogno di spiegarlo ulteriormente.
Il film polverizza il mito della frontiera. Può spiegarci questo aspetto?
Il fatto di smantellare il mito della frontiera è l’idea che sta dietro al film. La situazione politico-economica del paese è complessa. Gli emigranti disprezzano la cultura di appartenenza e non capiscono che altrove le cose non sono certo migliori. Volevo rovesciare questo aspetto: noi possiamo imparare da quelle culture indigene, piuttosto che loro dalla nostra. Il mio è un tentativo di cambiare un paradigma radicato, perché al di là delle barriere che ci dividono condividiamo lo stesso pianeta. Quanto tempo sia necessario non lo so, l’importante è muovere i primi passi in questa direzione.